di Gabriele Gabrielli
Imprenditore, executive coach e consulente è Consigliere delegato di People Management Lab S.r.l Società Benefit e BCorp. Ideatore, co-fondatore e presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, insegna Organizzazione e gestione delle risorse umane all’Università Luiss Guido Carli. Il suo ultimo libro è: (a cura di), Allenarsi per il futuro Sfide manageriali del XXI secolo, FrancoAngeli, 2021.
Dirigere con autorità, oppure impegnarsi per creare le condizioni affinché i collaboratori possano raggiungere i loro obiettivi di sviluppo personale e quelli dell’impresa? Leader e manager si muovono da sempre tra questi due principi. Douglas Mc Gregor, che chiamava teoria X e teoria Y le differenti strategie e stili di comportamento che possono adottare i capi, indicava con “principio scalare” il primo e con “principio di integrazione” il secondo. Tutti vorrebbero avere collaboratori bravi, efficienti ed efficaci, con spirito di iniziativa, veloci. Nella pratica i limiti a questa collaborazione a chi sono addebitabili? All’uomo o alla direzione aziendale? “Se i dipendenti sono indolenti, indifferenti, poco propensi ad assumersi responsabilità, intransigenti, non creativi, non collaborativi”, secondo lo studioso americano, la causa è da rinvenire “nei metodi di controllo e di organizzazione aziendale”. L’adozione di questi due principi comporta evidentemente implicazioni profondamente diverse per la leadership e la gestione delle risorse. È più efficace seguire il principio scalare o il principio di integrazione? Conviene ostinarsi a pensare che l’uomo medio ha “ripugnanza” per il lavoro che vorrebbe evitare o immaginare invece che le persone cerchino soddisfazione e auto- affermazione nel lavoro e che queste siano correlate con la produttività e i risultati?
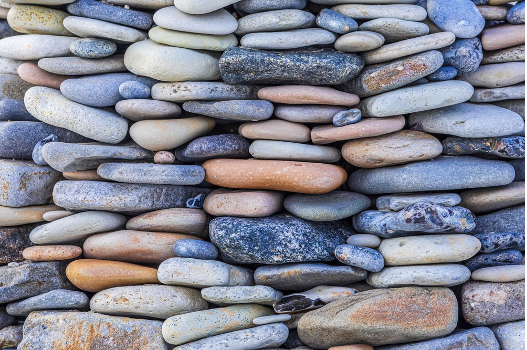
La questione oggi ritorna di grande attualità a fronte dei nuovi scenari organizzativi che renderanno strutturale, almeno in numerose realtà, lo smart working. L’autorità infatti, intesa come ricorso alle classiche leve della gerarchia e alla forza dei suoi strumenti, sembra debba lasciare il passo a forme di leadership e management diverse. Il controllo e le modalità di supervisione, per esempio, perdono lo smalto che avevano quando il lavoro era organizzato in presenza, una modalità che consentiva di usare lo sguardo, l’ascolto dei mormorii che echeggiavano lungo i corridoi e i silenzi assordanti degli open space. La – presenza in altre parole consentiva ai manager di avere costantemente il polso della situazione e suggeriva interventi tempestivi. Si potrebbe obiettare che della necessità di un cambio di paradigma nella gestione delle persone se ne parla almeno da trent’anni. Vero. E’ anche vero però – prendendo a prestito un altro passaggio di McGregor tratto da L’aspetto umano dell’impresa (FrancoAngeli, Milano, 1986) che “il principio scalare è ormai saldamente installato nel modo di pensare dei dirigenti [NdR: eravamo nel 1960], mentre le implicazioni del principio di integrazione non vengono recepite facilmente”.
Dirigere con autorità e affidarsi al controllo oggi, ancora più rispetto al passato, non basta e soprattutto non serve. Occorre altro per motivare le persone e raggiungere gli obiettivi dei quali comunque i capi devono rispondere. Occorre costruire le condizioni perché le potenzialità dell’uomo possano esprimersi pienamente e la loro autonomia sia riconosciuta effettivamente. Come fare? Teoria e pratica suggeriscono che buona parte della demotivazione, scarsa cooperazione e insoddisfazione dei collaboratori dipende da come il manager li tratta. Per questo bisogna prepararsi e mettere in campo pratiche efficaci di leadership e people management che aiutino le persone a “ragionare con la propria testa” riponendo in loro fiducia.
La fiducia è tra i fattori che influenzano maggiormente la prestazione e per costruirla è necessario spendere diversamente il tempo di chi dirige. Le persone vogliono essere riconosciute. Platone l’aveva capito. Nella Repubblica scrive che “gli uomini aspirano a ricevere giudizi positivi sul loro valore e dignità.” Da parte di chi? Certamente dai colleghi ma anche, e forse ancor di più, dai capi. Quando le persone si sentono riconosciute provano orgoglio, altrimenti provano rabbia, perché viene offesa la loro identità. Bisogna saper cogliere allora questa occasione per convertire il tempo destinato al controllo del “principio scalare” alla comunicazione e creazione di senso che richiede il “principio di integrazione”. Un impegno che assicurerà i suoi frutti soprattutto nel medio periodo e questo può costituire un serio ostacolo alla trasformazione culturale ed operativa dei manager. Come conciliare questa positiva tensione alla costruzione di fiducia con l’ansia da prestazione nel breve alimentata dalla ideologia della competizione e dalla pressione sui numeri? Un dilemma la cui soluzione, evidentemente, non può essere spostata a valle ma va indirizzata e testimoniata a monte.
Pubblicato su Hr On Line, nr. 2/2021






Lascia un commento